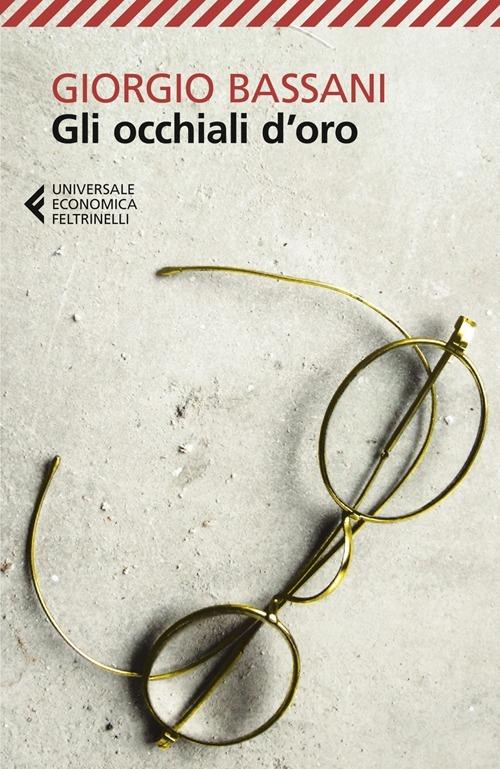
Lo scrittore Giorgio Bassani ambienta a Ferrara la vicenda narrata nel romanzo Gli occhiali d’oro (Universale Economica Feltrinelli), apparso la prima volta nel 1958.
Protagonista è un giovane studente ebreo della facoltà di lettere che racconta in prima persona la storia di cui è parte in qualità di testimone: tutto ruota intorno alla figura di un affermato medico, apprezzato e noto per la sua cultura e raffinatezza.
In un tempo, quello fascista, in cui vige la purezza della razza e la rispettabilità sembrerebbe che non siano macchie nella vita personale e privata del medico, ma tutto cambia quando cominciano a circolare sul suo conto voci relative ad una sua presunta omosessualità.
La scrittura di Giorgio Bassani incede rapida e precisa tra le evoluzioni della trama che con infinita maestria si apre lentamente a mostrare le ferite che da superficiali diventano sempre più profonde e insanabili.
La società che gravita intorno al medico si trasforma in una tenaglia: la feroce stretta con cui lo si tiene in scacco avrà per lui conseguenze nefaste.
Gli occhi del mondo sono puntati sul medico, su ciò che fa o non fa, su quello che dice o non dice, sui luoghi che frequenta e quando, e così i giudizi e le opinioni da benevoli in un attimo mutano in ostili.
Bassani allarga con perizia le maglie della vicenda, mostrando con sofferta accuratezza quanto il male sia capace di radicarsi nelle menti e nelle anime quasi senza che le stesse si accorgano di quello che sta succedendo.
Il turbinio moraleggiante creato ad arte da una visione idealistica e perciò lontana dalla complessità della realtà fagocita chi prova a vivere con tutta l’onestà intellettuale di cui è capace la propria difformità dal contesto che lo circonda.
Leggiamo: “Mai nulla di praticato in pubblico, sia pure in esclusiva fase di approccio, mai nulla di scandaloso. Bensì rapporti accuratamente clandestini con uomini di mezza età e di condizione modesta, subalterna. Con individui discreti, insomma, o, almeno, tenuti in qualche modo a esserlo”.
Non è sufficiente il rispetto per chi vive senza provocare dolore agli altri; ad un certo punto, per il bene di una collettività anestetizzata dalla propaganda e da teoremi di presunta superiorità razziale, è necessario, anzi imprescindibile, penetrare nel privato, raschiarlo, esaminarlo con la lente d’ingrandimento, analizzarlo fino all’ultima cellula, scinderlo in mille pezzi e poi darne un giudizio implacabile e definitivo.
Tutto questo condurrà allo stravolgimento di un’esistenza fino a quel momento votata ad esercitare con cura e attenzione un mestiere di altissimo valore morale.
Ciò che consegue è l’emarginazione, la solitudine, l’estromissione da un contesto civile da cui, a quanto pare, si è stati accettati solo in modo superficiale.
Alla stessa emarginazione sarà destinato il narratore di questa storia: le sue origini ebraiche gli varranno da lì a poco, dopo l’emanazione delle leggi razziali da parte del regime fascista, una fine anche peggiore della ghettizzazione.
La morsa intorno al medico e al narratore si stringe con soffocante rapidità e nel contempo l’umanità che gravita intorno a loro si fa sempre più partecipe del gioco macabro della violenza e della bestialità.
La massa informe e brulicante di voci senza vita non fa che assembrarsi intorno a chi è già stato virtualmente espulso a causa della diversità, palese o celata, del proprio modo di vivere, di pensare, di agire, di parlare, di sentire.
Lo scrittore, con drammatica propensione alla verità, fende di netto la questione che pone al centro sempre la minoranza, formata da dissidenti del pensiero, come fosse una catasta di legno da incendiare per il godimento voluttuoso di uomini e donne pronte a barattare la propria coscienza con la trionfale appartenenza alla maggioranza.
La diversità è inaccettabile: in essa brulicano le tentazioni di quelli che hanno la forza e il coraggio di ergersi contro il potere, contro ogni potere precostituito, che al contrario praticherà sempre una pressione fortissima perché nessuno osi ribellarsi.
Nel breve romanzo di Bassani gli occhiali d’oro, indossati dal medico, diventano il simbolo di una diversità che non può più essere occultata, ma che anzi esplode in maniera inaccettabile e che per questo deve essere repressa con dura fermezza.
Quando leggiamo: “Che cosa dovrei fare?”, lo interruppi con impeto. “Accettare di essere quello che sono? O meglio adattarmi ad essere quello che gli altri vogliono che io sia?”, comprendiamo subito quanto dolore, quanta spietatezza, quanta rassegnazione c’è in un essere umano travolto dall’atrocità di chi non sa più riconoscersi nell’altro.
Nell’attimo in cui la società si impone su chi sente e vive la propria diversità in modo naturale e sincero si perde la possibilità di credere nel bene, nella speranza, nella bontà.
Vigono allora il disprezzo, l’isolamento, il tormento e la sfiducia. Da qui il passo verso il punto di non ritorno è breve.
Leggiamo: “Il senso di solitudine che mi aveva sempre accompagnato in quei due ultimi mesi diventava se mai, proprio adesso, ancora più atroce: totale e definitivo”.
Si lotta, si crede, si tenta di resistere finché il desiderio di autodistruzione non diventa l’unico obiettivo possibile in un mondo in cui le parole annientano e i gesti conducono alla morte.
Dopo aver letto l’ultimo rigo del romanzo, è inevitabile chiedersi: ce la farà questa umanità a recuperare il senso del vero e del giusto?
Luciana De Palma
